Le cinque domande del 2020 secondo Open (e i suoi esperti)


Buoni propositi e scommesse sul futuro. Come ogni anno prima di San Silvestro non si parla d’altro. Abbiamo deciso di provarci anche noi, facendo domande ai nostri esperti di fiducia o provando a rispondere su quelli che – secondo Open – saranno i temi caldi del 2020.
Sarà l’anno della svolta per la lotta al cambiamento climatico?

Per rispondere a questa domanda è sufficiente esaminare cosa è successo durante la COP25. Al lettore che va di fretta anticipiamo il nostro profondo pessimismo per il nuovo anno, con la speranza di dover fare rettifica quanto prima.
Delle due settimane di autoanalisi dei rappresentanti dei Paesi che condividono una pesante responsabilità nei cambiamenti climatici, restano un fallimento. Al netto dell’eco giunto a Madrid delle grandi lotte per ridurre le emissioni, buona parte dei propositi annunciati a Parigi nel 2015 mancano l’appuntamento del 2020, mentre si continuano a rimandare i compiti più ambiziosi.
Persino la Cina che secondo alcuni osservatori sembrava volesse mettere la testa a posto, con le sue centrali a carbone in costruzione non ce la racconta giusta – pacca sulla spalla per le sue risaie meno impattanti – e il Brasile non è da meno, nonostante sia reduce dei gravi incendi in Amazzonia.
Questa intransigenza riguarda anche altri due grandi inquinatori: Stati Uniti e India. Non un minimo compromesso sembra essere stato trovato tra gli interessi economici delle potenze vecchie e nuove e quei Paesi poveri, che risentono maggiormente delle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Il problema riguarda anche le disuguaglianze nelle popolazioni, definito in un recente studio «Apartheid climatico». Così finisce il più lungo vertice mondiale sul clima, coi suoi 200 delegati internazionali: col rinvio all’appuntamento di Glasgow previsto per l’anno prossimo, dell’elaborazione delle tanto attese regole sul mercato del carbonio.
Il principale ostacolo contro cui si è andati a cozzare è stato quello di trovare nuove regole per il mercato globale del carbonio, la COP25 avrebbe dovuto partorirle, invece è stata un aborto.
Fa appena eccezione l’Unione europea, che ha elaborato un piano con scadenza entro il 2050. In generale maggiori impegni sono stati dimostrati dai piccoli emettitori, al contrario ci si aspettava di più da quelli grandi.
La futura presidente del vertice di Glasgow Claire Perry O’Neill la prende con maggiore filosofia, sostenendo che l’assenza di un accordo è sempre meglio di un cattivo accordo. Ma forse per molti detrattori delle politiche di riduzione delle emissioni l’attesa dell’accordo è essa stessa un accordo.
La frustrazione raggiunge l’apice l’11 dicembre, quando oltre 300 attivisti di Fridays for future sono stati cacciati a malo modo dalle uscite di sicurezza, per poi essere riaccolti in un secondo momento. Sono almeno 70 i Paesi che non possiedono piani sufficienti a contenere le emissioni di carbonio, secondo stime dell’Onu.
Per le strade di Madrid erano 500mila i manifestanti in corteo, ispirati da Greta Thunberg. La direttrice di Oxfam Intenational Chema Vera fa eco alla delusione dell’attivista svedese:
«Il Mondo sta gridando all’azione ma questo summit ha risposto con un sussurro. Le nazioni più povere sono in corsa per la sopravvivenza, eppure molti governi si sono appena mossi dai blocchi di partere. Invece di impegnarsi in tagli più ambiziosi delle emissioni, i Paesi hanno discusso di tecnicismi».
Il tanto auspicato spirito di cooperazione tra i popoli non sembra al momento essere pervenuto, in totale contrasto con quel che avveniva nelle piazze della capitale spagnola; per non parlare dei moniti lanciati dalla Comunità scientifica.
Cosa dovrebbe succedere di sostanzialmente diverso per il 2020? Solo l’affermarsi di nuove amministrazioni negli anni a venire, nei paesi a cui è chiesto maggior impegno – e che possono trainare tanti altri col loro esempio (Usa e Cina) – potrà smuovere la situazione, attraverso il lavoro di legislatori e diplomatici più lungimiranti.
Donald Trump verrà rieletto?

«C’è una differenza tra gli studiosi e gli indovini: i primi rispondono soltanto alle domande a cui è possibile rispondere, per questo gli indovini sono più popolari». Per Fabrizio Tonello, docente di Scienze politiche all’università di Padova e specialista del sistema politico americano, sapere se Donald Trump verrà rieletto rientra nella seconda categoria, quella della chiaroveggenza.
Il sistema elettorale americano, basato su un unico «Collegio» elettorale e non sul voto popolare rende infatti complicato rispondere a questo quesito. Questa assemblea, formata dai delegati dei 50 stati, non rispecchia sempre il volere della maggioranza dei cittadini: sia nel 2000 (Bush-Al Gore) che nel 2016 (Trump-Clinton), è diventato presidente il candidato che aveva ottenuto menovoti su scala nazionale.
«Fin dal giorno in cui è entrato in carica, Trump non ha mai ottenuto una percentuale di consensi maggioritaria: il suo rating oscilla tra il 40% e il 50%. Cosa ancora più importante, la percentuale di americani che disapprovano la sua politica è stata costantemente superiore al 50%, quindi un democratico in grado di aggregare i voti di tutti coloro che sono contrari di Trump dovrebbe essere in grado di batterlo», spiega Tonello, aggiungendo che durante il suo mandato Trump non ha fatto nulla per conquistare i voti dei democratici.
Nonostante questo, esistono vari elementi che fanno pensare che Trump verrà rieletto. Oltre al fatto che tradizionalmente negli Stati Uniti i Presidenti ottengono un secondo mandato, il sistema dei Collegi Elettorali potrebbe nuovamente darla vinta a Trump. Se le coste sono tendenzialmente democratiche e il centro e il sud in genere repubblicani, l’attuale capo della Casa Bianca, spiega Tonello, è molto forte «nell’unica regione della nazione che rimane incerta tra i due partiti, il Midwest: Michigan, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin. Lo spostamento di poche migliaia di voti in uno qualsiasi di questi quattro stati può decidere le elezioni».
Dei 538 delegati che compongono il collegio, un recente sondaggio dell’università della Virginia ne ha attribuiti 248 a Trump e 248 al suo avversario democratico. Rimangono quindi incerti 42 voti, quelli di Arizona, Wisconsin e Pennsylvania, insieme a uno dei voti del Nebraska. «Ciò significa che l’elezione del prossimo novembre sarà uno scontro all’ultima scheda e che non è neppure impossibile un pareggio: se il candidato democratico vincesse in Wisconsin e Nebraska e Trump arrivasse in testa in Arizona e Pennsylvania, nel collegio elettorale si determinerebbe una perfetta parità, con 269 delegati per parte», afferma il professore.
In questo caso, secondo la Costituzione, il compito di eleggere il Presidente passerebbe alla Camera, dove però ogni Stato ha diritto a un solo voto. Questo favorirebbe nuovamente Trump perché gli stati rurali controllati dai repubblicani sono più numerosi.
«La minaccia di una recessione dell’anno elettorale – che ostacolerebbe seriamente le possibilità di rielezione di Trump – sembra essersi allontanata. L’economia statunitense sta procedendo con una bassa disoccupazione e la modesta crescita dei salari è bilanciata da una bassa inflazione, questo è uno scenario positivo per Trump», conclude Tonello, «Molto dipenderà dalle primarie dei democratici e dalla loro scelta di un candidato alla presidenza sufficientemente autorevole».
L’Italia avrà un nuovo governo?

La domanda è nell’aria, nelle stanze della politica e non solo: litigano, si dimettono, entrano ed escono parlamentari da tutti i gruppi della maggioranza. Insomma, questo governo, quanto dura?
Molte sono le variabili da tenere sotto controllo e parecchie saranno in campo già dopo le feste: ci sono le elezioni regionali alle porte e il risultato in Emilia Romagna è tutt’altro che scontato.
Prima dell’appuntamento del 26 gennaio, però, giusto il 23, la giunta del Senato sarà chiamata a votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini.
Negli ultimi mesi i Cinque stelle hanno continuato a registrare defezioni proprio in questo ramo del parlamento e quel voto potrebbe essere un banco di prova importante (ovviamente si vedrà molto di più al momento dell’arrivo in aula) tanto più che si discute proprio della condotta che ha impedito alla nave militare italiana Gregoretti, di portare a terra un gruppo di migranti.
Open ha chiesto un commento a Giovanni Diamanti, cofondatore dell’agenzia Quorum Youtrend. Secondo Diamanti, quello attuale è «un governo molto instabile, come dimostra il caso Fioramonti».
È vero però che c’è un equilibrio di fondo, una ragione che potrebbe tenere in piedi il governo sebbene tutti i protagonisti siano molto deboli: «I tre partiti di governo ad oggi non hanno particolare interesse a tornare al voto, questo li unisce». Ovviamente, aggiunge Diamanti, bisognerà guardare al voto dell’Emilia Romagna e delle successive consultazioni regionali.
Ma c’è anche un’altra incognita: «Il movimento non può perdere altri voti al senato altrimenti il governo potrebbe tornare ad essere in bilico. Attendiamoci colpi di scena anche per il 2020».
Le proteste ad Hong Kong andranno avanti?

Da sei mesi le proteste a Hong Kong raccolgono la partecipazione di milioni di cittadini. E anche per il 2020 nell’ex colonia britannica le richieste e le manifestazioni di piazza della popolazione non si arresteranno. Ne è sicuro Francesco Sisci, ricercatore senior presso l’Università popolare cinese e Direttore dell’istituto Italiano di cultura di Pechino.
«La situazione si è normalizzata nell’isola – dice Sisci – Le richieste dei cittadini non sono state accettate, quindi sicuramente il movimento pro- democrazia continuerà a organizzarsi nelle strade per ottenere dalla Cina delle garanzie».
Ma per conoscere il futuro di Hong Kong c’è un’altra variabile da tenere in considerazione ed è la conflagrazione del problema dell’ex colonia britannica con quello di Taiwan: «Nei prossimi giorni le elezioni presidenziali a Taiwan potrebbero vedere con ogni probabilità la vittoria della signora Tsai Ing-wen». Già presidente in carica, prima dell’inizio delle proteste a Hong Kong, Tsai era data come perdente.
«Ha una linea ostile a Pechino – dice Sisci -. Dopo sei mesi di proteste a Hong Kong, la sua popolarità è cresciuta. La popolazione è preoccupata che quello che sta facendo Pechino a Hong Kong possa essere replicato a Taiwan».
Durante la sua presidenza Tsai non ha mai escluso la possibilità di dichiarare l’indipendenza formale dalla Cina: «Taiwan è di fatto indipendente, ma formalmente si riconosce parte di un’unica Cina. Questo è un ambiguo compromesso che fu raggiunto nel 1992 e che ha mantenuto fino ad avere uno status quo nella normalizzazione dei rapporti».
Ma le proteste pro democrazia, e la brutale repressione della polizia, hanno cambiato la percezione dei taiwanesi che ora temono una forte ingerenza di Pechino: «Il partito democratico progressista dell’isola teme che la Cina possa soffocare lo spazio economico diplomatico-commerciale di Taiwan e sostiene che il modo migliore per riconquistarlo sia ricorrere a un referendum per l’indipendenza», chiarisce Sisci.
Se Tsai, in caso di rielezione, dovesse scegliere un referendum «La Cina passerebbe dalle parole ai fatti». Ma le azioni della Cina saranno indissolubilmente legate alla variabile Hong Kong «perchè i rapporti tra le due isole sono speculari. C’è il pericolo che la questione di Hong Kong possa accendere una fiamma ben più pericolosa a Taiwan dove non si può escludere la possibilità di una guerra aperta».
Quale sarà la novità tecnologica dell’anno?

中国, Regno di Mezzo. Non è esattamente un aggeggio ma potrebbe essere questa la parola chiave per la tecnologia nel 2020. O meglio, nell’anno del Topo che comincerà il 25 gennaio, stando al calendario cinese. Regno di Mezzo infatti è l’antico nome della Cina ed è proprio qui che i colossi tecnologici di tutto il mondo hanno inziato a guardare con paura.
Non troppo tempo fa gli smartphone che arrivavano dalla Cina erano definiti i «cinesoni», dispositivi che abbondavano nelle dimensioni dello schermo e nelle specifiche tecniche ma che non garantivano perfomance a lunga durata. Ora Huawei è arrivata al secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, con una percentuale di mercato del 15,8% (i dati sono del secondo quadrimestre 2019).
Ma parlare dell’avanzata cinese nella tecnologia non sarebbe certo una novità. Eppure nel 2019 sono successe tre cose che hanno aperto a nuovi scenari: lo sbarco di TikTok in Occidente, le dichiarazioni di Guo Ping sul 5G e il ban e l’HMS.
1. Lo sbarco di TikTok in Occidente
Se avete uno smartphone Android, aprite il vostro Play Store. Andate nella sezione classifiche per vedere le app in evidenza. Al primo posto c’è, ormai saldo, TikTok, il social cinese che ha interessato anche i team di comunicazione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.
Come abbiamo spiegato nella nostra Guida a TikTok per over 25, questa piattaforma si basa soprattutto sulla condivisione di video. I contenuti originali sono ridotti al minimo: bisogna solo reinterpretare i trend, che siano challenge, canzoni da cantare in playback o domande a cui rispondere.
A netto dei contenuti, TikTok vince il titolo di primo social network cinese che riesce a diffondersi nel mercato occidentale. Fino al suo arrivo, infatti, tutte le piattaforme social più utilizzate erano Made in Usa, dai lontani blog di Msn a Instagram.
L’arrivo di TikTok ha portato con sé anche dubbi, morali e pratici, legati alla censura. Se provate a caricare anche solo uno spezzone delle proteste di piazza Tienanmen, l’applicazione non vi permetterà nemmeno di pubblicare il video. E così, in diversi casi, anche per i video delle proteste a Hong Kong.
Senza contare le denunce per le azioni del governo contro gli uiguri, la minoranza islamica della regione dello Xinjiang. Denunce che devono essere travestite da video di make up per aggirare la censura.
Nel 2020 quindi ci saranno due motivi per osservare con attenzione TikTok. Il primo sono le strategie che metterano in campo le big tech degli Stati Uniti per non perdere il loro soft(ware) power. Il secondo invece è la risposta che darà TikTok alle accuse di censura. La Cina dovrà cambiare per conquistare l’Occidente?
2. Le dichiarazioni di Guo Ping sul 5G
«Siamo l’unica compagnia a livello mondiale a poter creare una rete 5G su larga scala». Il rotating chairman di Huawei Guo Ping aveva lanciato questo petardo durante il Mobile World Congress di Barcellona nel febbraio 2019.
Ai tempi, la discussione sulla sicurezza delle reti 5G progettate dal colosso di Shenzhen era molto attiva, spinta soprattutto dalle agenzie din intelligence statunitensi che erano arrivate addirittura a minacciare di non condividere più informazioni con gli Stati che si sarebbero affidati alla Cina per la costruzioni di queste infrastrutture.
Perplessità che in Italia hanno continuato a turbare il Parlamento, fino ad arrivare all’11 dicembre, con l’approvazione della relazione del Copasir, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. In questo testo si sollevano dubbi sulle garanzie date da un 5G cinese.
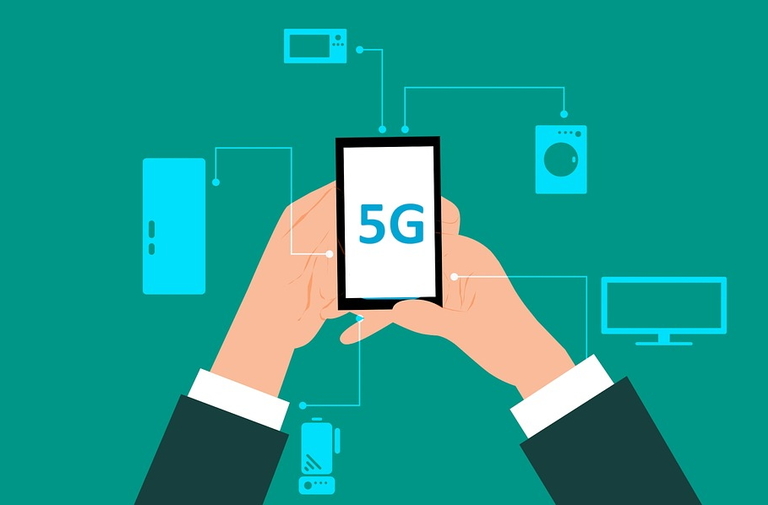
Dopo diverse audizioni con i vertici dei servizi segreti, dal rapporto del Copasir è emerso che non ci sarebbero abbastanza garanzie sull’indipendenza dal governo cinese delle aziende che operano nel campo del 5G. Nello specifico stiamo parlando di Huawei e della più piccola Zte.
Il 5G in Italia dovrà essere fatto. Ma se non con la tecnologia cinese, con chi? Secondo Antonio Capone, professore nella facolta di Ingegneria delle Telecomunicazioni del Politecnico di Milano, le opzioni non sarebbero molte altre.
3. HMS, ovvero come Huawei punta all’indipendenza da Google
Mentre in Italia andava in scena la crisi del primo governo Conte, il resto del mondo, ma soprattutto il resto dei mercati, erano interessati a un partita di ben altre dimensioni: lo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti. Una battaglia feroce, che nei periodi di tensione più grande aveva fatto temere a milioni di utenti Huawei di non poter più usare app le app di Google, come Gmail o Maps.
Proprio per questo l’azienda di Shenzhen ha accelerato i lavori per arrivare a creare un ambiente software che permetta ai suoi dispositivi di funzionare anche senza il supporto di Google. E così Huawei ha deciso, oltre che lavorare al proprio sistema operativo, di lanciare una serie di iniziative per finanziare lo sviluppo di app native: gli Hms appunto, i Huawei Mobile Services in contrapposizione dei Google Mobile Services.
In tutto questo c’è però una domanda. Huawei è il secondo produttore di telefoni Android al mondo. Google non farà niente (anche in termini di pressioni sul governo Usa) per evitare di perdere un cliente cosi importante??
