Il fatto della settimana: la crisi Iran-Usa e il conflitto in Iraq


Sono passati quasi diciassette anni dall’inizio della guerra in Iraq (20 marzo 2003). Nessun altro conflitto ha condizionato così tanto la politica estera americana in Medio Oriente negli ultimi anni e segnato così profondamente l’immaginario collettivo di due generazioni. Quando dimenticheremo l’attentato alle Torre Gemelle l’11 settembre 2001 o le immagini degli iracheni che abbattono la statua di Saddam Hussein a Baghdad o quelle delle camionette nere di Daesh che varcano il confine tra la Siria e l’Iraq?
Gli ultimi eventi – il raid americano al generale Soleimani e la risposta iraniana – hanno riacceso il conflitto su suolo iracheno dopo che, nel 2019, Daesh era stata pressoché sconfitta (quanto meno la sua proiezione territoriale) e il presidente americano Donald Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe americane dalla confinante Siria.
Ma perché lo scontro tra Usa-Iran è riesploso proprio in Iraq e perché, dopo l’uccisione di Soleimani, il Parlamento iracheno ha approvato la richiesta di espulsione delle truppe americane? Quali sono le alleanze sul territorio e cosa vanno cercando Usa e Iran in Iraq?
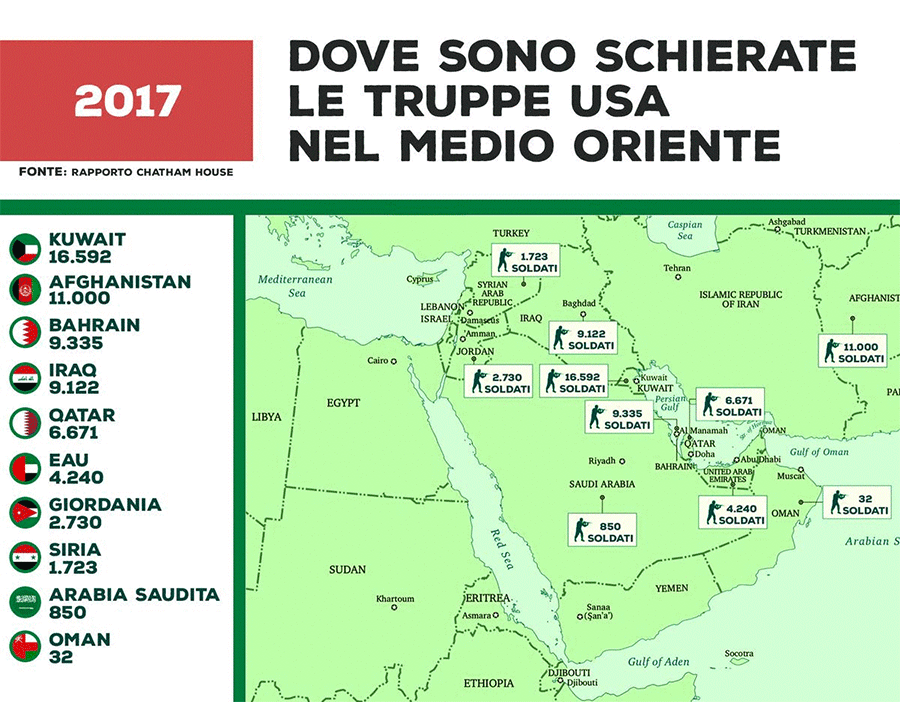
Il conflitto Usa-Iran
Quella vissuta da Stati Uniti e Iran è la tragedia delle grandi potenze, così come teorizzata dal politologo statunitense John Mearsheimer. In un ordine globale caratterizzato dall’anarchia, le aspirazioni egemoniche dell’uno e dell’altro possono portare a un unico risultato: la guerra.
Negli ultimi giorni l’allerta si è alzata per la possibilità di uno scontro diretto tra i due Paesi. Ma non è sempre stato così. Leggere i rapporti tra i due Paesi come un’escalation naturale e lineare che è giunta fino ad oggi è fuorviante.
La storia dell’Iran e dei suoi rapporto con l’America è una storia che parte da lontano, e che ha visto mutamenti, promesse e minacce, alti e bassi, costanti avanzamenti e indietreggiamenti.
Nel 1979 l’Iran passò dall’essere uno dei pilastri della politica estera americana in Medio Oriente contro una penetrazione sovietica a nemico numero uno dopo la rivoluzione islamica con la sua forte impronta anti-imperialista e anti-americana, frutto dei lunghi anni di ingerenza statunitense nella politica iraniana e dell’appoggio al regime autoritario dello shah Mohammad Reza Pahlavi.
In quegli anni la crisi del 1980 dei 52 ostaggi americani detenuti all’ambasciata di Teheran segnò la psiche di un’America che riconobbe per sempre nell’Iran il rivale da combattere.

Così come per il governo iraniano l’aiuto americano a Saddam Hussein durante gli otto anni di guerra combattuti con l’Iraq (1980-1988) segnarono una ferita talmente profonda per la neonata Repubblica Islamica da plasmare, dieci anni dopo, la politica asimmetrica iraniana in Iraq e nel resto del Medio Oriente.
Ma, anche in quei lunghi otto anni di guerra, le relazioni tra Iran e Stati Uniti non furono mai di totale rottura. A riprova di ciò fu lo scandalo dell'”Iran Contra”. Un accordo che prevedeva la consegna a Teheran, via Israele, di missili anticarro di fabbricazione americana per la guerra contro Saddam Hussein. In cambio, Teheran avrebbe usato la sua influenza in Libano per liberare gli ostaggi americani e incanalato fondi per i guerriglieri anticomunisti Contra che combattevano il governo di sinistra sandinista in Nicaragua.
L’apertura di Khatami
Gli anni che seguirono la fine del conflitto con l’Iraq furono gli anni del pragmatismo del presidente Ali Rafsanjani e della ricostruzione economica favorita dall’elezione di Mohammed Khatami, il fautore del “dialogo tra civilità”. Il governo di Khatami favorì il riavvicinamento tra i due Paesi. Teheran aveva disperatamente bisogno di allentare la pressione economica dovuta alle sanzioni e Washington aveva bisogno di alleati nella regione nella lotta ai talebani.

Ma, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle, duramente condannato dalla Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, l’Iran si trovò improvvisamente inserita in quell’ “asse del male” delineato da George W. Bush Jr nel discorso sullo stato dell’unione, il 29 gennaio del 2002. Insieme a Iraq e Corea del Nord, l’Iran delle riforme e dell’avvicinamento a Washington si trovò pugnalato alle spalle, ed etichettato come “uno stato canaglia” che, nelle parole di Bush, sarebbe stato il prossimo dopo l’Iraq a subire l’attacco americano.
Parole non certo di distensione per un Paese che nel 2004 decise di affidarsi alla presidenza di Mahmud Ahmadinejad e alla sua forte retorica anti-sionista e anti-americana.
Obama-Rouhani e l’accordo sul nucleare
Nel 2013, nel mezzo dei lunghi negoziati sul nucleare, il panorama internazionale cambiò ancora. Con la rielezione di Barack Obama e l’ascesa al governo per la prima volta del riformista Hassan Rouhani, le prospettive di una distensione definitiva tra i due Paesi sembravano alla portata di tutti. Due anni dopo, il 14 luglio del 2015, l’Iran firmò l’accordo sul nucleare promosso dal gruppo dei 5+1 con la mediazione di Bruxelles.

Un accordo che segnò l’apertura dell’economia iraniana e la fine di parte delle sanzioni americane con visite di Rouhani in tutto il mondo, la prima proprio in Italia. Ma l’elezione di Trump e la sua volontà, sventolata in campagna elettorale, di voler mettere fine al “peggior accordo” della storia chiuse ancora una volta la prospettiva di un rapporto pacifico, stabile e duraturo.
Iraq, dalla cooperazione anti-Isis allo scontro
Eppure negli ultimi anni gli Stati Uniti e l’Iran avevano trovato un modo di collaborare in Iraq contro un nemico comune: l’Isis. La prospettiva di uno stato estremista sunnita al confine con il proprio Paese non piaceva all’Iran (i due Paesi sono a maggioranza sciita anche se in epoca moderna l’Iraq ha spesso avuto governi sunniti, come nel caso del regime di Saddam Hussein).
Attore razionale alla costante ricerca di stabilità, Teheran non avrebbe potuto stare in disparte di fronte al diffondersi alle porte di casa di un terrorismo islamico che minacciava di destabilizzare la regione. Ma ci sono sempre stati anche motivi più prosaici: i buoni rapporti di vicinato servono anche a tutelare il commercio e la cooperazione energetica.
Per gli Stati Uniti, sempre attenti alle risorse petrolifere irachene, l’Isis rappresentava un nemico da sconfiggere per tutelare non solo gli interessi economici regionali, ma anche nell’ottica della “crociata” iniziata da George W. Bush contro il terrorismo di matrice islamica (“The War on Terror”) e della “stabilizzazione” del Paese nel dopo-Saddam.
La guerra – iniziata nel 2003 e dichiarata conclusa da Bush nel 2004 – aveva aperto a una nuova stagione di violenza settaria nel Paese, sfociata in seguito nell’arrivo dell’Isis.
Nonostante Barack Obama avesse decretato il ritiro delle truppe americane dall’Iraq, gli Stati Uniti hanno mantenuto alcuni soldati – i dati di fine 2019 parlano di circa 5mila soldati – principalmente per addestrare le forze di sicurezza irachene alle prese con l’Isis. L’Iran invece ufficialmente non ha truppe in Iraq, ma ha dato il suo sostegno al governo iracheno nella battaglia contro l’Isis e ha fornito materiale bellico ai peshmerga curdi.
La strategia iraniana in Iraq
Ma la presenza dell’Iran in Iraq si è fatta sentire soprattutto tramite il sostegno a diverse milizie sciite – presenti in tutta la regione, consentendo a Teheran di raggiungere una profondità strategica che va dal Mediterraneo all’Indo – mobilizzate inizialmente nel 2014 contro l’Isis ma la cui importanza è andata crescendo negli anni, arrivando a controllare la maggioranza di seggi nel Parlamento iracheno.
Si tratta delle Forze di Mobilitazione popolare che contengono al loro interno diversi gruppi, tra cui Kata’ib Hezbollah, i cui esponenti hanno preso d’assalto l’ambasciata americana a Baghdad a fine dicembre 2019 dopo l’azione militare ordinata nei loro confronti dal Pentagono, a sua volta una risposta ad altri attacchi contro le basi Usa.

I gruppi che compongono le Forze di Mobilitazione Popolare milizie, oltre ad essere temute da una parte della popolazione irachena, sono nemici giurati degli Usa e dei suoi partner regionali, come Israele e Arabia Saudita. Da questo conflitto nasce l’escalation di violenza che è deteriorata con l’uccisione di Soleimani.
Adesso bisognerà attendere per vedere se la fragile tregua, trovata tra Iran e Usa dopo la rappresaglia iraniana e il lancio di missili contro la base Usa a Baghdad, comporterà una riduzione o un aumento – per vie dirette o indirette – nella presenza militare dei due Paesi in territorio iracheno e se il risultato sarà una pace duratura oppure il peggioramento nella guerra tra fazioni, con un possibile ritorno dell’Isis.
Quella tra Iran e Stati Uniti è una delle grandi tragedie politiche dei nostri tempi, perché – citando le parole dell’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger – «ci sono poche nazioni al mondo con cui gli Stati Uniti hanno meno ragioni per cui discutere e più interessi compatibili dell’Iran».
I leader americani potrebbero ancora attingere in modo creativo allo storico serbatoio di buona volontà iraniana verso gli Stati Uniti per realizzare iniziative che la fine diplomazia di Teheran sarebbe disposta ad accettare.
Con il contributo grafico di Vincenzo Monaco
Leggi anche:
- Uccisione Soleimani, Trump: «Nel mirino c’era l’ambasciata, come a Bengasi»
- «L’Iran continuerà coi raid contro gli Usa finché rimarranno in Medio Oriente»
- Iran, architetto issa bandiere bianche sui siti Unesco “minacciati” da Trump
- La guerra con i droni: dai 563 attacchi di Obama alla “falciatrice” di Trump
- Crisi Iran-Usa, come è stata evitata una guerra che nessuno voleva. Il retroscena del New York Times
- Iraq, attacchi alla base Usa a nord di Baghdad: almeno 4 militari iracheni feriti
- Iraq, «diversi feriti tra le truppe Usa» nell’attacco iraniano alla base di Al-Asad
