Alec Ross: «Obama frenò la Cina ma non capimmo il pericolo delle Big Tech. L’Europa? La smetta di fare l’arbitro» – L’intervista


«Gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in una competizione delle grandi potenze. Durante gli anni di Obama, Pechino ha sempre voluto essere riconosciuta come l’altra grande potenza globale ma l’ex presidente non gliel’ha mai concesso. Oggi questa realtà è compiuta e il vertice di martedì lo riflette in pieno». Alec Ross, che dell’amministrazione Obama è stato giovanissimo consigliere per l’innovazione, guarda con occhi critici i nuovi equilibri geopolitici trainati da big tech, rabbia populista e paradisi fiscali. Nel suo ultimo libro I furiosi anni venti (edito in Italia da Feltrinelli) Ross, docente alla Business School dell’Università di Bologna, non fa sconti a nessuno.
Partiamo dall’Europa.
«Gli europei sono come spettatori seduti nei sedili dello stadio a guardare le grandi potenze gareggiare, ma quello che succede in campo potrebbe danneggiarli».
Lei dice che l’Europa deve smetterla di porsi come l’arbitro che dà le regole ed entrare nel campo di battaglia. Anche l’esito della Cop26 trainato da Usa, Cina e India indica che i giochi si svolgono altrove?
«La mentalità europea deve necessariamente cambiare. Bisogna smetterla di guardare sempre a cinesi e americani, a cominciare dal cambiamento climatico. Gli Stati Uniti, come la Cina, hanno incentivi e ostacoli molto diversi da quelli europei. Lo sviluppo della Cina, ad esempio, richiede ancor tantissimo combustibile fossile. Mentre gli Stati Uniti, a differenza dell’Europa, hanno un enorme problema di consenso rispetto a questo tema: la maggior parte degli europei ha capito che dobbiamo fare qualcosa per evitare il disastro. Negli Stati Uniti, invece, il 50 per cento delle persone riconosce il problema, ma l’altro 50 per cento lo rifiuta».
In che modo?
«Per loro il problema non esiste oppure non è sufficiente a far alzare i prezzi del petrolio o di altri prodotti. Cosa vuoi che siano 1 o 2 gradi in più rispetto ai miliardi di dollari che si perdono?»
Provi a rispondere lei.
«Quello che non vedono sono le opportunità economiche che vengono dalla green economy, il cui sviluppo vale circa mille miliardi di dollari. Chi riuscirà a guidare questa transizione sarà il protagonista non solo nella ricerca ma anche nel commercio dei prodotti e dei servizi legati all’ecologia. Penso che come gli Stati Uniti sono stati il cuore della nascita e della crescita di internet, così l’Europa può essere il cuore delle tecnologie per la sostenibilità e questo avrebbe un valore non solo per l’ambiente ma per l’economia. Può nascere oggi un Amazon o un Google del mondo della sostenibilità e sono sicuro che possa essere europeo».
Ci spera o vede segnali in questa direzione?
«Lo vedo negli esempi già messi in campo nei paesi nordici dove ci sono sia le competenze, sia la volontà. La mia visione è basata sull’osservazione delle condizioni della ricerca, del commercio ma anche dell’ambiente politico e imprenditoriale».
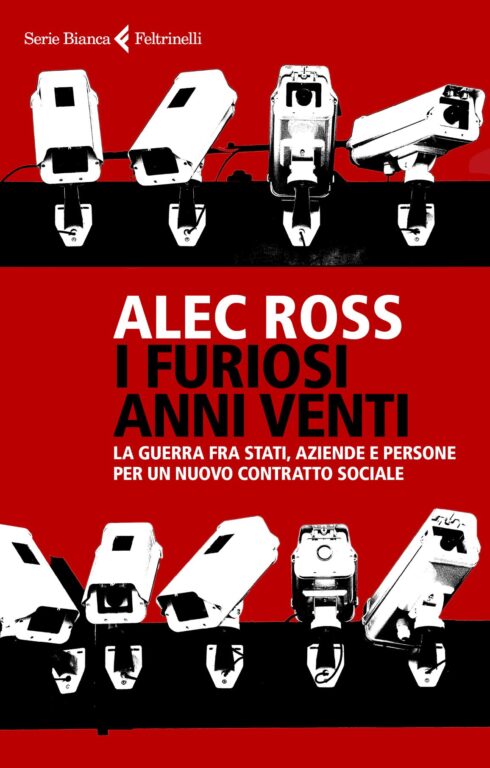
Quali sono i segnali politici europei che trova incoraggianti?
«Prima di tutto le parole dei leader. I capi di governo europei parlano di questi temi in modo diverso rispetto agli asiatici o agli americani. Inoltre la nuova generazione di imprenditori è molto interessante: negli ultimi anni c’è stata una grande ondata di venture capital in Europa e questo ha portato a un boom di piccole imprese innovative. Solo dieci anni fa l’ecosistema di start-up in Europa, con alcune eccezioni, era debole. Un test importante è arrivato con la pandemia quando gli imprenditori europei hanno deciso di non andare a Londra, in California o Dubai, ma sono rimasti in Europa. C’è un esempio che mi piace molto fare e riguarda l’Estonia, dove un’imprenditrice tech, Karoli Hindriks, ha fondato anni fa una piattaforma per la mobilità del lavoro in Europa, Jobbatical. Quel progetto oggi è un successo perché gli ingegneri e i manager europei non si trasferiscono negli Stati Uniti, in Cina o in India ma restano nei paesi dell’Unione europea».
Scrive che in Italia ci sono imprenditori che hanno inaugurato un nuovo modello di imprenditoria e un approccio diverso al capitalismo.
«Il modello di capitalismo stakeholder (in cui l’attenzione non è solo verso il profitto degli azionisti ma soddisfa gli interessi di tutti gli attori coinvolti ndr) esiste da tempo in Italia perché c’è un aspetto della vostra cultura che bene si lega a questo modello: il capo di un’azienda in Italia non è solo il leader dell’azienda ma anche dei dipendenti, delle famiglie dei dipendenti, del Comune. C’è un impegno verso la comunità che attraversa le generazioni, si tramanda di padre in figlio. Spesso noi americani siamo critici con gli italiani quando si tratta di business ma dobbiamo riconoscere che ci sono aspetti della cultura italiana che possono aiutare il capitalismo a funzionare meglio».
Questo approccio italiano al capitalismo ha però mostrato spesso la sua faccia peggiore: familismo, clientelismo, incapacità di crescere.
«L’alternativa che arriva dagli Stati Uniti è brutale: una specie di futuro distopico e iper individualistico alla Mad Max. Come diciamo noi, la nostra più grande forza è anche la più grande debolezza».
Il governo Draghi sta facendo abbastanza per favorire l’innovazione?
«Onestamente io su questo sono critico con gli italiani: guardano sempre a Roma! Di sicuro la politica ha un ruolo chiave ma non è l’unico. Eppure troppo spesso gli italiani parlano solo dei politici. Negli Stati Uniti questo non accade: noi creiamo la nostra realtà, se Washington ci può aiutare bene, altrimenti facciamo da soli. Gli amministratori delegati italiani parlano sempre di Roma e del governo. Quando lo fanno con me io li blocco subito: “Pensi che a Jeff Bezos gliene freghi qualcosa di chi c’è a Washington? O che agli amministratori delegati importi di quello che accade al Congresso?”. No! Solo quando c’è un grande problema che li riguarda».
Per riscrivere il “contratto sociale” di cui parla nel suo libro la politica però sembra essere indispensabile. O no?
«Le regole e le strutture del mondo del lavoro in Italia sono ferme agli anni Settanta, mentre per la Giustizia siamo al Medioevo. Per non parlare del ruolo delle donne e della nuove generazione: ai tavoli di chi prende le decisioni continuano a esserci troppi uomini anziani. Ma il cambiamento non deve partire dal palazzo: se volesse Confindustria da sola potrebbe innescare molti di questi avanzamenti. Non è la politica che può creare opportunità per i giovani imprenditori in Italia, sono gli investitori, le grandi famiglie con i soldi che dormono con i risparmi chiusi nelle banche. Non c’è bisogno di nuove regole, di leggi sui giovani o sulle donne. Ci sono reti di potere in ogni comune italiano. E non mi riferisco solo alle arcinote – Torino con la famiglia Agnelli. In quasi tutte le città italiane ci sono 15, 20 personaggi con un’influenza sostanziale per guidare questi cambiamenti culturali. Gestiscono tutto nelle città, scelgono i sindaci: il loro sistema collega il mondo di business con il mondo politico a livello locale. Loro possono cambiare le cose».
Quanti di quelli che ha conosciuto in Italia lo fanno davvero?
«Ci sono degli esempi positivi. E non mi riferisco solo ai personaggi arcinoti come Brunello Cucinelli, ce ne sono altri meno conosciuti. Avete bisogno di un’ondata di cambiamento e certo non può arrivare dai “padri”: non si può pretendere da un uomo di 80 anni che cambi la sua mentalità sulle donne nelle imprese».
A proposito di ottantenni che cambiano le cose, Joe Biden li compirà tra un anno. Come vede la sua presidenza?
«Il Paese che guida non è diviso in due ma in tre: ci sono i repubblicani, il centro e poi c’è l’ultrasinistra. In questa situazione, vinceranno di sicuro i repubblicani perché l’ultra-sinistra americana non può affermarsi fuori dalle due aree costiere. La maggior parte degli americani non vuole il socialismo, né guerre contro la polizia».
Cancel culture, woke culture, politicamente corretto. C’è davvero una guerra culturale in atto negli Stati Uniti?
«Negli Stati Uniti il clima è molto pesante. Io vorrei dire solo una cosa: la risposta al suprematismo bianco non deve essere il suprematismo woke (attenzione verso le micro-aggressioni di cui sono state e sono vittime le minoranze ndr). Rispondere agli estremismi con gli estremismi porta solo distruzione. La cultura woke è tremenda perché contesta tutti i fatti e tenta di ricreare il mondo con l’obiettivo primario di punire. Come sa, io parlo ogni giorno della necessità di elevare il ruolo delle donne all’interno delle comunità ma non credo che per riuscirci dobbiamo punire tutti i maschi bianchi. Questo è illiberale, mentre io sono un vero liberale. E tifo per pensieri liberi da questo tipo di fascismo della sinistra».
Tassare i ricchi è una mossa che va incontro agli elettori di centro o alla sinistra?
«Arriva dall’ultrasinistra ma penso che anche il centro sia d’accordo, e anche io lo sono. Quando parliamo della tassazione dei ricchi parliamo in realtà di una tassazione equa che riguardi i capitali, non il lavoro».
Innanzitutto le aziende tecnologiche.
«Hanno troppo potere ma, come scrivo, siamo arrivati a un momento di transizione. Dobbiamo scegliere: o saremo governati da questi ragazzi miliardari della California o dalle democrazie. Non sono sicuro di quale sarà la risposta. Perché credo che, nonostante tutto, Zuckerberg continui a dormire sonni sereni. Il rumore non cambia niente: non importano gli articoli dei giornali, i discorsi dei grandi personaggi a Bruxelles. L’unica cosa che può cambiare questa cultura sono le conseguenze e i risultati. Biden odia Facebook e tutta quella comunità ma vediamo quali saranno i risultati».
Lei è stato un tecnoentusiasta ai tempi dell’amministrazione Obama, che ha permesso a queste aziende di crescere senza limiti. C’è qualcosa di cui si pente?
«Oggi Biden ha attuato una global minimum tax per le multinazionali. Avremmo dovuto intervenire sulle tasse 15 anni fa. È evidente che l’unica cosa che conta per farli cambiare è agire sui soldi».
E perché non avete fatto nulla?
«Avevamo a che fare con soggetti troppo opachi e difficili da capire. Abbiamo sbagliato a non creare fin da subito un sistema di tassazione equo e commisurato ai loro guadagni, ma all’epoca forse non ne capivamo l’importanza».
In copertina: Alec Ross, elaborazione grafica di Vincenzo Monaco
Leggi anche:
- Missile russo distrugge satellite e mette in pericolo gli astronauti in orbita. Gli Usa: «Azione sconsiderata»
- Il primo summit virtuale tra Biden e Xi, tra parole di miele e minacce a Taiwan – Il video
- Facebook cambia nome, si chiamerà Meta. Zuckerberg: «Si apre un nuovo capitolo». E il titolo vola a Wall Street
- Facebook papers, spuntano 10 mila pagine su allarmi ignorati su odio e fake news: perché Zuckerberg rischia la crisi più minacciosa
- Cop26 verso l’accordo finale: incontro decisivo tra Usa, Ue, Cina e India sull’abbandono del carbone
