Usa 2024, Ben Smith: «Non sarà l’età a penalizzare Biden. Le idee di Trump? Popolari in tutto il mondo» – L’intervista


Se c’è un giornalista in America che ha capito prima degli altri l’impatto di internet sulla politica, questo è di sicuro Ben Smith. Newyorkese di nascita, 48 anni, una carriera nell’innovazione giornalistica – dagli scoop di Politico alla direzione di Buzzfeed, fino all’attuale impresa Semafor -, Smith ha raccolto nel suo ultimo libro Traffic (Altrecose) le avventure umane ed economiche dei pionieri del web degli ultimi due decenni, tracciando le tappe che hanno trasformato internet da luogo di ottimistica libertà a fonte di disinformazione. Lo incontriamo a Milano durante una tappa del tour europeo del libro.

Ha vissuto in prima linea gli ultimi 20 anni di internet. Ripercorrendoli, cosa non avevamo capito?
«Solo scrivendo il libro ho realizzato quanto i semi del populismo dell’ultradestra fossero presenti fin dall’inizio nelle storie che ho raccontato. Credevo che i protagonisti principali sarebbero stati Jonah Peretti (fondatore di Huffington Post e Buzzfeed ndr) e Nick Denton (fondatore di Gawker ndr) ma in realtà sono i populisti di destra che già all’epoca erano estremamente connessi con i progetti che stavano rivoluzionando internet: da Steve Bannon ad Andrew Breitbart fino al fondatore di Vice News Shane Smith. Tutti erano legati tra di loro, tutti concentrati sulle opportunità del nuovo mondo delle reti sociali, tutti ossessionati dal traffico. E mentre questo universo prendeva forma cosa facevano i liberal?».
Osannavano i social network?
«Io ricordo quando più o meno nello stesso periodo, durante il suo secondo mandato, Obama visitava la sede di Facebook rilasciando dichiarazioni congiunte con Mark Zuckerberg. Questo accadeva non perché Facebook o le altre piattaforme stessero con i democratici, ma perché quelli erano considerati luoghi naturali per i progressisti. Non dimentichiamo che tutti i fondatori del web erano ragazzi del college. All’epoca nessuno capiva cosa stesse succedendo».
L’ascesa di Donald Trump verso la presidenza degli Stati Uniti nasce da lì?
«Quando Trump è salito al potere in tanti hanno voluto vedere dietro la sua elezione la mano di Facebook e lo zampino dei russi, ma la verità è che quando è stato fatto fuori da queste piattaforme la sua fama non si è ridotta. Non voglio negare che i social network abbiano aiutato Trump, ma per spiegare il suo successo basta guardare il mondo: quello che vende è popolare. Zuckerberg lo ha aiutato perché era l’essenza del divisivo di cui Facebook si alimentava. Trump faceva litigare le persone e questo piaceva a Menlo Park. A un certo punto, quando ero direttore di Buzzfeed, avemmo accesso ai dati sui sentiment degli utenti della piattaforma: il 99% riguardava Donald Trump. Clamoroso. Abbiamo vissuto in una dimensione tale per cui da un lato c’erano i populisti che dicevano cose fortissime sui social, dall’altro i media e le istituzioni liberal che correvano a prendere le distanze».
Eppure le interferenze straniere sulle elezioni Usa sono state provate in diverse occasioni.
«I russi hanno avuto un impatto reale con la disinformazione non lo nego, ma ci sono storie – prendi Cambridge analytica (la società legata alla Russia che aveva lavorato per la campagna elettorale di Trump, accusata di aver rubato i dati di milioni di utenti Facebook ndr) – che non hanno alcun senso. Quando la gente dice che Trump è stato eletto per vicende come quella di Cambridge Analytics rispondo che di certo i russi non hanno più impatto di un politico locale».
E adesso?
«La politica americana è molto stabile da anni. La differenza tra i due schieramenti è molto sottile. Il vero tema sono tutte quelle persone che non sanno neanche che a novembre si vota, e arriveranno a pochi giorni dalle elezioni senza sapere niente».
Quanto conta il fattore età nella scelta degli elettori?
«Io credo che la questione dell’età di Biden sia molto sopravvalutata. Le strade sono infuocate, spesso fuori controllo, le persone sono esauste e spaventate. Biden si presenta come un politico decente che dice ai suoi elettori: “Torniamo alla normalità”. Molti credono che non sia totalmente in controllo delle sue facoltà, ma non penso che decideranno in base a questo».
E cosa sarà determinante?
«Le idee di Trump sono popolari in tutto il mondo. Votarlo è un segnale di nostalgia per la grandezza americana del ventesimo secolo. Esprime il rigetto per i cambiamenti degli ultimi due decenni: l’immigrazione, la globalizzazione, le élite, le questioni di genere. La verità è che l’economia americana è dinamica, la transizione climatica si sta dimostrando efficace qui e i business tecnologici vanno alla grande. Eppure, invece di evidenziare le conquiste, dal 2016 il più grande bottino elettorale per i democratici continua a essere l’odio per Trump. A New York il candidato repubblicano Lee Zeldin ha perso perché ricordava Trump».
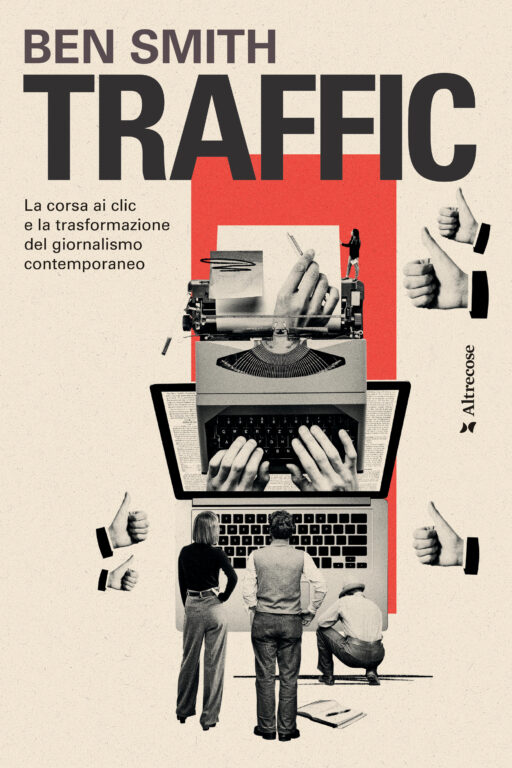
Nelle elezioni di mid-term l’aborto ha svolo un ruolo molto importante. Sarà così anche stavolta?
«L’aborto è un grande tema e come tutti i grandi temi ha un effetto sulle urne. Qui vige un’equazione abbastanza semplice: se l’aborto è prioritario nella testa delle persone, ne beneficeranno i democratici. Se lo è l’immigrazione, ne beneficeranno i repubblicani. Trump lo sa bene e infatti preme sui migranti e ha preso le distanze dall’aborto, addossando la responsabilità alle corti di giustizia. Ma ogni settimana c’è una donna in Texas o in Arizona che vive una situazione terribile e questo il 99% degli americani – di qualsiasi schieramento – lo rifiuta. Non è ideologia, è un problema reale. La guerra a Gaza sta spostando l’attenzione, ma se la paura per le donne tornerà per i democratici sarà un bene».
Quanto conta il fattore Gaza nell’elezione di novembre? Dai sondaggi sembra che Biden a causa del sostegno a Israele stia perdendo sempre più consensi tra giovani, che hanno infuocato i campus, e tra gli arabo-americani.
«Quelli che protestavano nei campus facevano molto rumore ma non erano tanti: centinaia, non migliaia. Gaza però è un problema vero per Biden, e l’amministrazione sa che non si sistema nei campus ma in Medio Oriente e quindi cerca di intervenire lì. Tutti a parlare delle proteste, ma c’è una guerra e la guerra è in Medio Oriente. Questo è molto americano».
Quanto contano oggi le piattaforme digitali nel determinare le scelte di voto delle persone?
«Quando sono arrivato al New York Times, nel 2020, stavamo assistendo alla fine di un’epoca: quella delle grandi piattaforme dove tutti erano negli stessi luoghi e leggevano le stesse cose. Stava iniziando l’era della frammentazione. Ora il panorama è molto variegato: ci sono una marea di podcast, siti, newsletter. Basta andare nella metropolitana di New York e guardare le persone con i loro auricolari: tutti stanno ascoltando qualcosa di diverso. C’è una storia politica totalmente nuova da raccontare ma è difficile dire quale sia proprio per via di questa frammentazione. Prima tutto ruotava intorno a enormi piattaforme social – Facebook in particolare, ma anche Twitter – dove la gente stava tutto il giorno a parlare di politica. Ora i cittadini ascoltano o leggono cose diversissime. C’è un recente sondaggio di Pew sul podcast preferito dagli americani e il risultato ci dà due notizie. La prima è che solo il 5% degli americani ha un podcast preferito, la seconda è che è quello di Joe Rogan. C’è un universo ampio, formato da tanti prodotti di piccola e media grandezza, di grande non c’è più niente.
Io credo che l’impulso primario sia dire che fa male all’informazione perché è un ritorno alle “bolle”, a spazi separati che – in quanto tali – tendono a estremizzarsi. Ma in realtà non è così. Sono le grandi piattaforme social che continuano a essere ostaggio dalla polarizzazione e dall’odio: è lì che vale ancora la regola che l’opinione più forte e più pazza vince. Al contrario, credo che questa frammentazione, fatta di podcast e newsletter, crei spazi più aperti e meno polarizzati. Se ci pensa, anche Joe Rogan nel suo podcast ha uno stile diverso, molto più calmo. Le persone sono stanche di questo costante odio promosso dai social media, di questa energia estrema. Non cercano più il combattimento politico».
Che spazio c’è per l’industria giornalistica in un panorama come questo?
«Io credo che anche sul fronte media tutto stia diventando più piccolo. Fox News è ancora molto potente, ma meno di come era in passato. Lo stesso vale per Nbc e Cbs e anche per il New York Times. È un grande business e sta funzionando ma di certo è meno influente di quello che era».
Lei è arrivato al New York Times insieme a molti altri “innovatori”. Siete andati tutti via…
«Sì, in quel periodo hanno preso un sacco di gente che veniva dalle nicchie di Internet. Di certo hanno imparato un sacco di cose ma molti erano professionisti che non avevano i loro valori: giornalisti molto creativi, e un po’radicali che non avevano nulla in comune con la Grey Lady. Alcuni sono stati buttati fuori, altri sono andati via ma in generale della gente assunta in quel periodo ne resta poca. Tante persone si sono unite ai media liberal avendo come unico obiettivo quello della lotta contro Donald Trump, ma non ha funzionato».
Leggi anche:
- Come sta Joe Biden? «Non è più sul pezzo ma se lo aiutano può farcela»
- La reazione di Trump alla condanna: «È un processo truccato, orchestrato da Biden». La risposta del presidente: «È una minaccia»
- Lo staff di Biden ingaggia De Niro per un evento dove è in corso il processo a Trump. L’attore lo attacca: «È un clown tollerato a New York» – Il video
- Usa 2024, doppio duello tv tra i candidati. Trump accetta l’invito di Biden: «Prepariamoci alla rissa» – Il video
- Usa 2024, Trump avanti su Biden in cinque stati in bilico su sei: il sondaggio del New York Times
- Joe Biden e la confessione sul suicidio dopo la morte della moglie e della figlia: «Ho pensato di andare sul ponte e saltare» – L’audio
