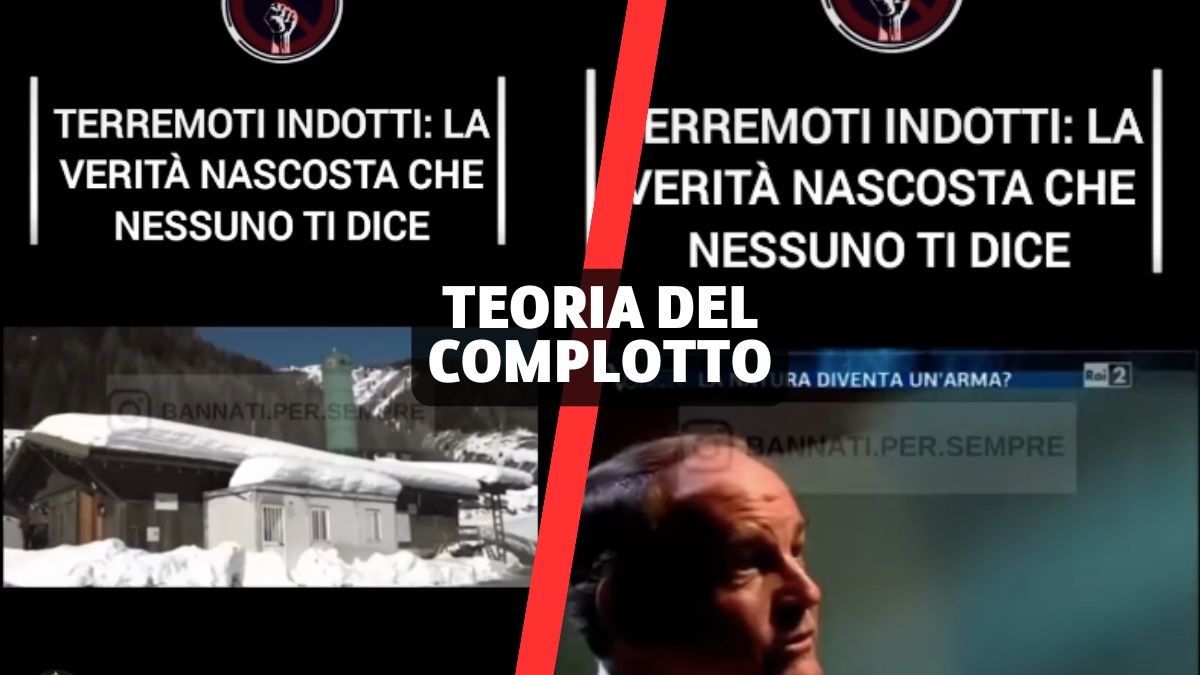Il terremoto in Myanmar e i danni «inspiegabili» a 1.300 km di distanza: «La faglia di Sagaing si è svegliata»


Il bilancio del terremoto in Myanmar sale a mille morti e 2400 feriti. Lo fa sapere la giunta militare del paese, mentre secondo le stime dello United States Geological Survey (Usgs) il conto finale dei decessi potrebbe arrivare a 10 mila. Ma cosa ha provocato le due scosse di magnitudo 7.7 e 6.4, 300 volte più forti di quelle di Amatrice? Una scossa così forte da aver provocato crolli a 1.300 chilometri di distanza? Gli esperti puntano il dito sulla faglia di Saigang. Si tratta di una linea retta da nord a sud per circa 1.200 chilometri. Collega la città di Mytkyna con il Mare delle Andamane. E proprio lungo questa linea sorgono i principali centri urbani del paese.
Myanmar, un terremoto inspiegabile
«Non è spiegabile che un terremoto provochi danni a oltre mille chilometri. A meno che non si ipotizzi un fenomeno di amplificazione locale: e in effetti Bangkok è costruita su giacimenti alluvionali in prossimità della riva del mare. Un contesto geologico che può aver amplificato una scossa arrivata da così lontano», dice oggi a Repubblica Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La placca indiana, premendo verso Nord-Nordest, ha generato l’Himalaya. Attualmente si verifica uno scivolamento laterale alla velocità di 3-4 centimetri l’anno. «Per adattarsi a tutto questo movimento laterale, si sono formate delle faglie che consentono alle placche tettoniche di scivolare lateralmente. È una di queste», dice Rebecca Bell, esperta di Tettonica all’Imperial College di Londra.
La faglia di Sagaing
La faglia di Sagaing ha la caratteristica di essere dritta come una linea retta. Proprio per questo i terremoti che genera possono investire grandi aree. «E più grande è l’area della faglia, più forte è il terremoto. Non a caso ci sono stati sei terremoti di magnitudo 7 o superiore in questa regione nell’ultimo secolo», conclude Bell. Secondo gli scienziati dell’università di Chulalongkorn la faglia accumula energia per lunghi periodi prima di rilasciarla. Ora entrain gioco la legge di Omori, che prende il nome dal geofisico giapponese che spiegò come dopo un grave evento sismico ha luogo un decadimento della magnitudo fino all’azzeramento. Poi la faglia riprende ad accumulare energia. In attesa della prossima scossa.
L’epicentro e la profondità
Doglioni spiega che per l’evento di ieri «si stima un epicentro compreso tra i 15 e i 24 chilometri di profondità. La grande incertezza dipende dal fatto che la rete di sismografi in Myanmar non è certo fitta come quella del Giappone o dell’Italia. Ma in ogni caso si è trattato di un terremoto poco profondo e i danni rischiano di essere importantissimi». E spiega:« Il terremoto del 2015 in Nepal fu originato dallo stesso fenomeno. Ma lì si era di fronte alla placca indiana, qui siamo sul suo lato orientale. È come un pugno che affonda in un cuscino. Le nocche provocano una compressione sul cuscino, mentre il dorso della mano esercita anche una sorta di trascinamento del tessuto».
La coppia sismica
Il geologo Mario Tozzi su La Stampa spiega che secondo le stime la prima scossa è stata 300 volte più distruttiva di quella di Amatrice e Norcia. La magnitudo Richter è infatti ordinata secondo una “scala” logaritmica, di cui non conosciamo il limite superiore (finora il sisma di M più alta è stato quello del Cile nel 1960, M=9,5). E che permette anche teoriche magnitudo negative. E soprattutto, la grandezza della superficie di faglia sotterranea è tale da generare terremoti di oltre M 8 Richter, come è spesso accaduto in passato. Proprio questa faglia può scatenare eventi “supershear”. Ossia sismi che scuotono il suolo a velocità superiori a quella delle onde di taglio (quelle trasversali), aumentando così il potenziale distruttivo.
Le possibili repliche
«In questo momento non si può abbassare la guardia, sussiste un rischio concreto di repliche che si potranno presentare anche a giorni se non a settimane di distanza», ha detto Andrea Billi, geologo dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Cnr, all’agenzia di stampa Agi.
«In questo momento la prudenza deve essere massima e solo se c’è la certezza di avere a disposizione strutture perfettamente antisismiche si può pensare a un parziale rientro della popolazione negli edifici. La zona interessata è una zona a forte rischio sismico. Il Myanmar è in prossimità di una faglia trascorrente destra che la divide dall’India, che, a sua volta, spinge verso l’Asia generando forze che poi scatenano questi fenomeni sismici. Si tratta di un meccanismo definito estrusione laterale geologica, che avviene quando c’è una indentazione. Cioè un blocco crostale, in questo caso l’India che tende ad andare verso nord, cioè a ‘indentare’, ossia ad entrare nel continente asiatico, portando a nord all’innalzamento della terra».
Eventi che si ripeteranno
«Quello stesso innalzamento che ha dato origine alla catena himalayana, e a ovest, e a est a spinte laterali che muovono le parti del blocco asiatico che vengono sollecitate, generando gli eventi sismici. Eventi quindi che non vanno considerati fenomeni isolati, ma che tenderanno a ripetersi», sostiene l’esperto. I terremoti sono relativamente frequenti in Myanmar. Tra il 1930 e il 1956 si sono verificati sei scosse di magnitudo pari o superiore a 7 vicino alla faglia. Secondo gli esperti, la debolezza delle infrastrutture, l’insufficienza dei servizi sanitari, soprattutto nelle zone rurali, e lo sviluppo anarchico degli agglomerati urbani hanno reso la popolazione particolarmente vulnerabile in caso di catastrofi naturali.