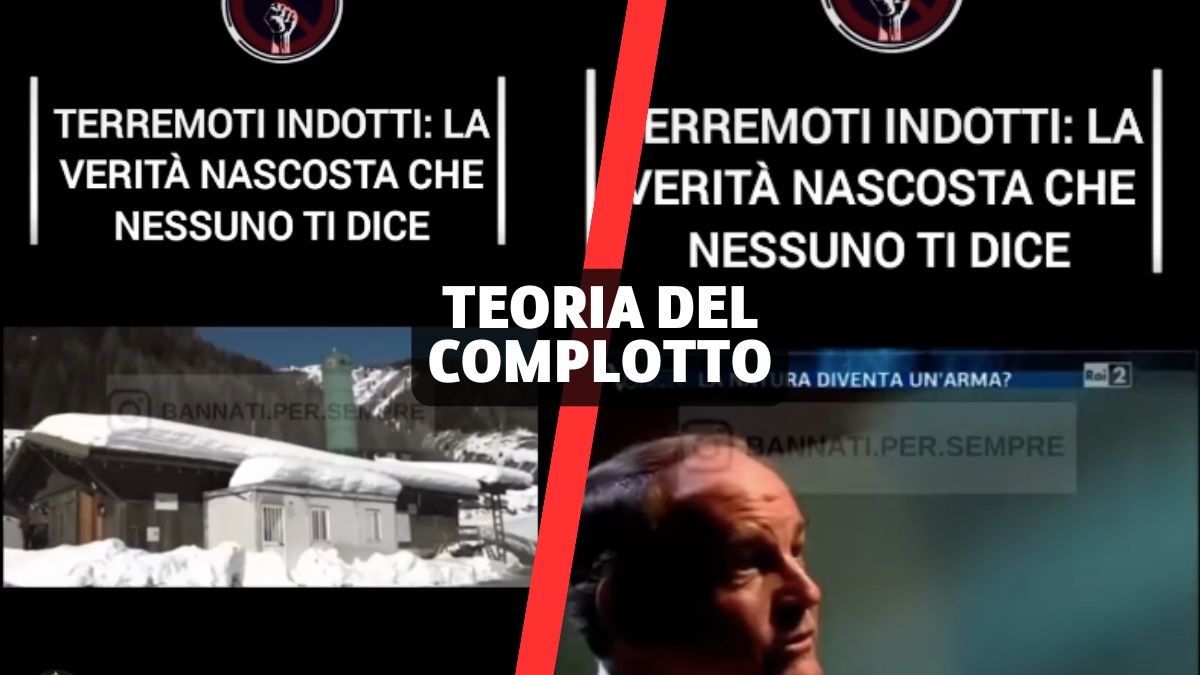L’epicentro del terremoto in Myanmar previsto nel 2011, lo studio ignorato sulla «lacuna sismica» e quale può essere la prossima


Nel 2011, due ricercatori avevano previsto con sorprendente accuratezza il terremoto che ha colpito il Myanmar il 28 marzo. Attraverso un’analisi approfondita degli eventi sismici precedenti, avevano individuato una «lacuna sismica» proprio nell’area in cui si sarebbe verificata la scossa. Non solo il luogo, ma anche la magnitudo erano stati anticipati con precisione, come riporta il Corriere della Sera.
Lo studio scientifico
Il 14 gennaio 2011, la rivista Geophysical Research Letters pubblicò un articolo del giapponese Nobuo Hurukawa e del birmano Phyo Maung Maung. I due studiosi avevano analizzato i terremoti di magnitudo superiore a 7 avvenuti dal 1918 lungo la faglia Sagaing, che attraversa il Myanmar da Nord a Sud, utilizzando mappe e dati GPS. Da questa analisi emersero due zone prive di attività sismica significativa, una delle quali situata in un tratto di 260 chilometri nel Myanmar centrale. Nel loro studio, conclusero: «Un futuro terremoto di magnitudo di circa 7,9 è atteso in questa zona. Poiché la nuova capitale del Paese è stata costruita proprio nei pressi della faglia, la sua popolazione è esposta a un significativo rischio sismico».
L’epicentro individuato nel 2011
La previsione si è rivelata straordinariamente accurata: il terremoto del 28 marzo ha avuto il suo epicentro esattamente nella lacuna sismica individuata nel 2011, con una rottura della faglia di 250 chilometri e una magnitudo di 7,7. Sebbene non fosse possibile stabilire con esattezza quando si sarebbe verificato il sisma, la sua probabilità era estremamente alta.

La faglia di Sagaing
La faglia Sagaing è di tipo trascorrente destro e si sposta di circa 1,8 centimetri all’anno. Essa rappresenta il confine orientale della collisione tra la placca Indiana, quella Euroasiatica e la placca della Sonda situata più a Sud. Secondo gli studiosi, questo movimento suggerisce che il tempo tra un terremoto e l’altro nella regione potrebbe essere relativamente breve.
La liquefazione delle sabbie
Hurukawa e Maung Maung avevano inoltre segnalato il pericolo della «liquefazione delle sabbie» nell’area colpita dal sisma, un fenomeno in cui il sottosuolo sabbioso, sollecitato dalle onde sismiche, si comporta temporaneamente come un liquido. Questo ha contribuito al crollo di edifici anche a Bangkok, in Thailandia, distante centinaia di chilometri dall’epicentro. Un fenomeno simile si era verificato nel 1985 a Città del Messico, colpita dalle onde sismiche di un terremoto avvenuto a 350 chilometri di distanza nell’oceano Pacifico, e in misura minore in Emilia Romagna nel maggio 2012.
L’altro «buco» sismico
L’altra «lacuna sismica» individuata dagli studiosi si trova più a Sud, nel Mare delle Andamane, parte dell’Oceano Indiano. La loro conclusione? «In questa “lacuna” un terremoto di magnitudo 7 non si verifica dal 1957. Un nuovo sisma potrebbe generare uno tsunami distruttivo nella parte settentrionale del Golfo del Bengala».